[Marco Bardazzi]
Di guerre culturali si parla continuamente in questo periodo. Dominano le cronache, dominano le analisi, infiammano la politica. Il professor Roy rifiuta, da un certo punto di vista, la tesi della guerra culturale per sé o del conflitto di valore.
C’è qualcosa di più profondo che emerge dal lavoro che ci presenta, cioè ciò che è in crisi – secondo lui – è la nozione stessa di cultura, ridotta ad un sistema di codici espliciti decontestualizzati, spesso globalizzati.
Parleremo molto della parola “globalizzazione”, dell’effetto che ha avuto su questi fenomeni che invadono le università e i salotti, invadono le lotte identitarie e questa serie di norme che limitano la cultura stanno entrando in tutti gli ambiti e sono anche alimentate e potenziate dal mondo della rete. Non a caso nell’edizione francese del libro mi colpiva molto che la copertina è fatta tutta di emoji, delle faccine sorridenti che usiamo tutti noi e dopo magari parleremo del perché.
Prima di partire con le domande volevo solo evidenziare quattro grandi fenomeni e mutazioni che il professor Roy indica nel suo libro e che sono la base da cui parte poi la riflessione.
- La prima è la mutazione dei valori con la rivoluzione individualista ed edonista degli anni 60.
- La seconda è la rivoluzione di internet.
- La terza è la globalizzazione finanziaria neoliberista.
- La quarta è la globalizzazione dello spazio e della circolazione degli esseri umani, le migrazioni, cioè quella che il professore chiama «deterritorializzazione», la perdita del territorio di riferimento.
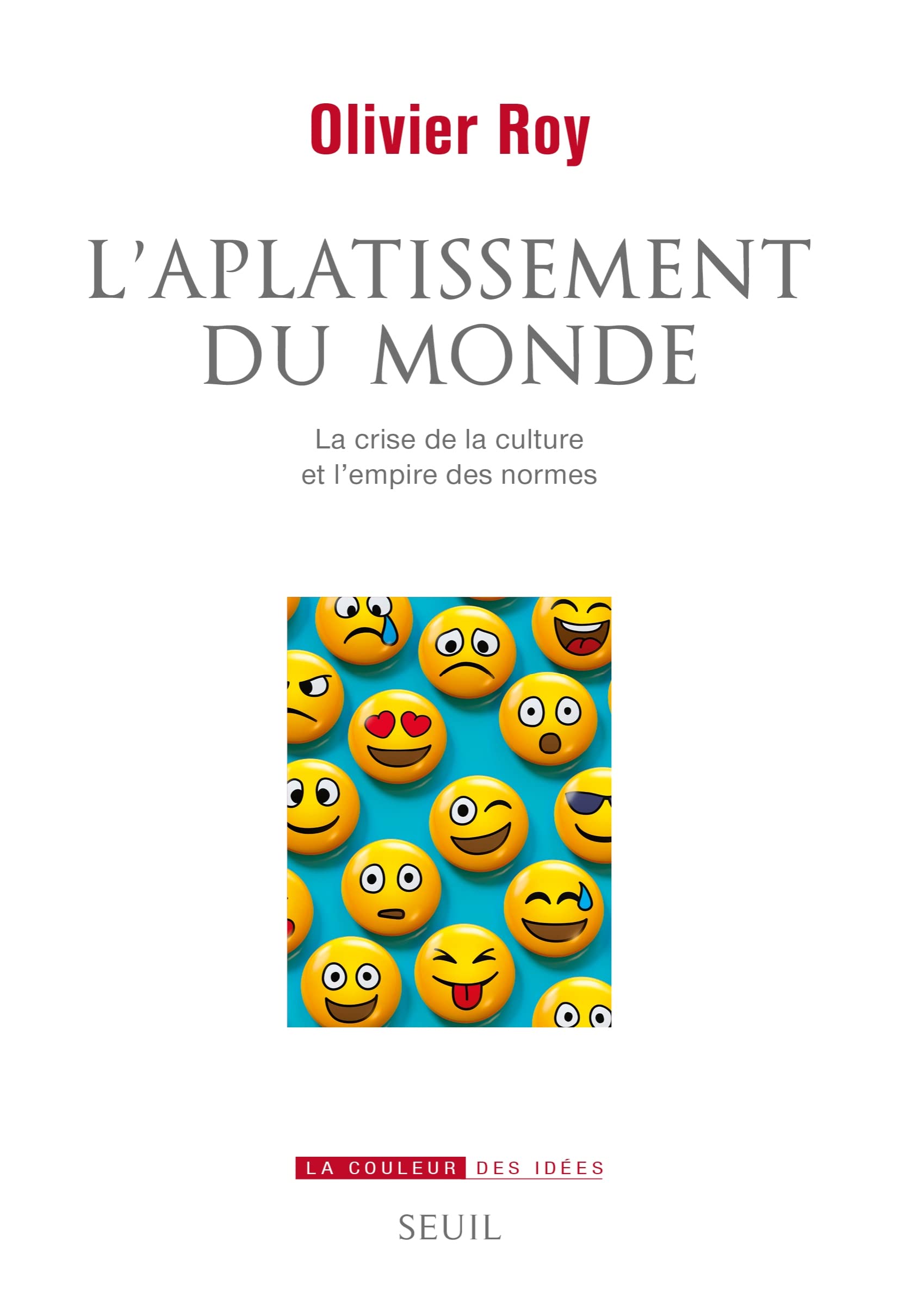 Da questi quattro fenomeni si parte per raccontare una crisi della cultura che è un po’ il tema del dibattito di stasera. Nel libro lei ricorda quanti si sono avventurati o hanno cercato di avventurarsi con opere accademiche, saggi, anche romanzi, su alcuni o su tutti questi terreni. Lei cita Fukuyama e La fine della storia, Samuel Huntington e Lo scontro delle civiltà per arrivare a Michel Houellebecq.
Da questi quattro fenomeni si parte per raccontare una crisi della cultura che è un po’ il tema del dibattito di stasera. Nel libro lei ricorda quanti si sono avventurati o hanno cercato di avventurarsi con opere accademiche, saggi, anche romanzi, su alcuni o su tutti questi terreni. Lei cita Fukuyama e La fine della storia, Samuel Huntington e Lo scontro delle civiltà per arrivare a Michel Houellebecq.
Il premio Pulitzer americano Thomas Friedman nel 2005 pubblica un libro che ha un titolo molto simile al suo: Il mondo è piatto. Lei oggi parla dell’appiattimento del mondo. Friedman attribuiva l’appiattimento al trionfo della globalizzazione. Ci racconta che cos’è, invece, questo nuovo appiattimento che lei descrive? È una degenerazione della globalizzazione?
[O. Roy]
La nozione di appiattimento del mondo, come ha detto anche lei, non è niente di nuovo e il trionfo della globalizzazione è stato sottolineato da svariati autori da una ventina d’anni a questa parte. Riprendo il grande tema di Friedman con il quale io sono d’accordo. Quindi prima di tutto il mercato libero. Il mondo oggi è uniformato a livello degli scambi economici e finanziari.
A livello dei valori Friedman nota che dalla caduta del muro di Berlino il mondo vive in accordo con dei valori positivi che sono i diritti dell’uomo e la democrazia. E poi ovviamente c’è internet che permette una comunicazione immediata con tutti. Permette uno scambio soprattutto grazie ad una lingua comune che io definisco globish, ovvero una sorta di inglese semplificato.
Friedman conclude che si va verso la pace. Vale a dire che questa globalizzazione, questa comunicazione immediata e questo accordo sui valori finirà con lo sfociare in una sorta di pace.
E qui le cose cominciano a complicarsi perché si vede che, invece, verso la pace non si sta andando. E non parlo soltanto delle guerre, delle vere guerre, ma anche dell’evoluzione del del discorso dell’odio su internet.
E adesso mi avvicino al punto, cioè la mia posizione: io non contesto Friedman. Si tratta piuttosto di dire quali sono le conclusioni, le conseguenze di questa globalizzazione che tutti riconoscono e al centro della mia tesi c’è il fatto che questa globalizzazione porta con sé una deculturizzazione generalizzata.
Questa deculturizzazione si svolge su due livelli. Il primo a livello dell’alta cultura, vale a dire le culture nazionali, la cultura che viene insegnata alle università e tutto quel corpus di grandi autori, poesia, arte, eccetera. E fin qui niente di nuovo perché la critica della cultura di massa, della crisi dell’università, dell’alta cultura, non è certo una novità. Viene fatta almeno da una quarantina d’anni e da tantissimi autori.
Noi ci troviamo in una situazione di crisi della cultura antropologica. Vale a dire ciò che all’interno di una comunità o di una società viene condiviso, cioè l’implicito delle visioni, dei valori, dei non detti, per esempio la lingua.
Il primo esempio è proprio la lingua. Non è un fatto nuovo che una lingua si imponga come lingua universale, per esempio il latino che si è proprio imposta come lingua di comunicazione universale per secoli. Il latino era anche portatore di una cultura che si apprendeva studiando opere letterarie e si faceva propria una cultura che era una cultura comune.
Allo stesso modo, nel XVIII secolo, il francese è diventata la lingua comune europea e chi imparava la lingua imparava anche la cultura. Invece oggi l’inglese che noi parliamo non è più connesso alla cultura inglese.
Quando ci troviamo in una riunione internazionale o viaggiamo il presupposto è che chi ci sta di fronte non parli bene l’inglese, quindi tutti gli interlocutori coinvolti parlano una lingua volontariamente povera: circa 1500 parole.
La cosa interessante è che questo impoverimento della lingua è incoraggiato dalle istituzioni europee. Ci sono delle direttive comunitarie sull’uso della lingua che incitano a usare una lingua, qualunque essa sia, evitando qualunque riferimento culturale preciso.
Per esempio non bisogna fare giochi di parole, non bisogna fare battute, non bisogna citare i classici, perché l’altro potrebbe non capire che cosa si sta dicendo. Non accuso certo Bruxelles, descrivo soltanto ciò che sta accadendo: una deculturazione della comunicazione.
Questo è un fatto che ritroviamo anche in quello che l’inglese definisce «body language», il linguaggio del corpo in cui si è incoraggiati ad utilizzare soltanto dei gesti predefiniti affinché l’interlocutore li comprenda senza possibilità di errore.
La mia tesi è che la deculturazione consiste nel rifiutare tutto ciò che è implicito per usare esclusivamente dei codici espliciti. Quindi entra in vigore un sistema di norme per stabilire tutto ciò che può essere detto e non deve essere detto, può essere fatto e non deve essere fatto. Ed è quello che io definisco una deculturazione a vantaggio di un sistema di codificazione e di norme.
[Marco Bardazzi]
Prof. Esposito, parliamo di globalizzazione come deculturazione e culturalizzazione, di globish che è questa lingua interessante dove si usano soltanto 1.500 parole, di un implicito che non si può più definire o usare ma tutto deve essere esplicito.
Tutto questo il prof. Roy lo inserisce in un cambiamento che ha caratteristiche antropologiche ben precise. Quindi vorrei chiederti di esplorare le conseguenze, dal tuo punto di vista, antropologiche e culturali dello scenario che descrive il libro del prof. Roy.
[C. Esposito]
Io credo che di questo libro bisogna scoprire l’implicito perché anche questo libro ha un suo implicito ed è quello che cercherò di rischiare stasera.
Anzitutto lasciatemi dire che quello che più colpisce leggendo questo libro è che non si tratta solo di un’analisi, peraltro molto ricca, molto informata, articolata, organica di diversi fattori emergenti nel contesto delle società più o meno avanzate contemporanee, ma quello che più colpisce è lo sguardo dell’autore, cioè l’esercizio di uno sguardo che cerca di capire il mondo e che ci permette, a nostra volta, di decifrare un po’ di più la postura della condizione umana oggi nel mondo.
Questa secondo me non è una notazione aneddotica o personalista, ma epistemologica, cioè dipende da uno sguardo, l’analisi.
Cito una delle frasi molto belle che il professor Roy dice, per esempio, a pagina 93 del suo libro: «ci vuole uno sguardo per dare significato ai dati, senza limitarsi a confrontarli tra di loro da un punto di vista strettamente statistico – come molta sociologia contemporanea fa – ma di interessarsi alle genealogie del significato».
Per fare un’analisi statistica basterebbe un algoritmo che è, per così dire, il metodo statistico fondamentale dell’appiattimento del mondo, il che, mi affretto subito a dire, non vuol dire assolutamente che la conoscenza statistica sia da rifiutare. Anzi, al contrario, proprio la conoscenza statistica, che non possiamo né rifiutare né accettare perché ci stiamo dentro, è la nostra condizione, è la nostra sintassi anche esistenziale e non soltanto cognitiva.
Proprio questa conoscenza statistica esige un essere umano, cioè esige che esista una storia particolare, un’esperienza personale, che dia il senso ai dati e per questo mi verrebbe da dire che la cosa più preziosa di questo libro è l’intuizione del suo autore.
Ci sono delle pagine molto belle, per esempio la pagina 94, in cui parla del rapporto tra conoscenza statistica e conoscenza intuitiva dicendo che quest’ultima è qualche cosa che non si può tradurre. È appunto un implicito, ma è un implicito talmente determinante che ogni esplicitazione, cioè ogni qualvolta noi riconosciamo il mondo, lo narriamo e anche lo manipoliamo, è all’opera quell’implicito, sempre.
Certo, nella deculturazione del mondo, nell’appiattimento, sembra svanire l’implicito. Ebbene in questo libro non è svanito, lo si ode tra le righe, lo si deve ascoltare, tra la messe di dati parla questo implicito, cioè questa intuitività per cui si cerca inevitabilmente il senso delle cose.
Anche il momento in cui sembra che questo senso dilegui, ci abbia abbandonato perché vince il calcolo, esattamente in quel punto, nel nostro riconoscere questa mancanza, c’è già in azione quell’implicito, c’è già una traccia della sua nascosta ma decisiva presenza.
Questo tema dell’implicito è veramente la perla di questo libro. Naturalmente è uno dei tanti temi, però ciascuno di noi legge un libro sempre perché gli muove certe corde. Il tema dell’implicito è quello che ha mosso le mie corde.
L’implicito o il non traducibile lo potrei definire come l’irriducibile, cioè qualche cosa che resiste alla traduzione, all’esplicitazione, ma non perché è qualcosa di misterico, non perché è qualche cosa di occulto rispetto a quello che si può dire, ma perché è la condizione per poter dire tutto. Possiamo anche chiamarlo l’io, un «io».
Lo diceva già Boezio. Che cos’è la persona? È qualche cosa di ineffabile di natura razionale, cioè al fondo della razionalità c’è un enigma irriducibile per cui noi possiamo stare al mondo, possiamo parlare, possiamo anche manipolare e ridurre.
Questo è il paradosso: ci vuole un «io» irriducibile anche per ridurre, non soltanto per esprimere tutta la potenza del mondo. Anche nella riduzione, anche nel momento della perdita o della mancanza, del dileguarsi del senso, non c’è mai un vuoto a perdere. Sempre dentro di sé c’è una traccia di significato.
L’interesse grande del libro sull’appiattimento del mondo di Oliver Roy è che ci aiuta – seguendo come lui guarda le cose – a ritornare a renderci conto di questo implicito.
È detto subito che non c’è niente di nostalgico in questo, nel senso che ci sono quelli di sinistra che leggono il suo libro in maniera speculare a quelli di destra, però, o come fuga in avanti o come rimpianto per il passato, possono trovare nutrimento per le loro aspettative, ma non è questa l’aspettativa.
Cioè non è quella di rimpiangere ciò che si è perduto, perché ciò che si è perduto noi lo siamo adesso, non è una cosa che non c’è più. Noi siamo questa perdita, è nella nostra esperienza che c’è questa mancanza, quindi interpella noi adesso. Né è una fuga in avanti, nel senso di una radicalizzazione dello svanimento, come l’avrebbe chiamato Ernst Jünger che si intendeva molto di queste cose, anche se agli inizi del Novecento.
Ebbene questa istanza intraducibile, questo implicito, è la sfida che ad ogni pagina emerge, anche se apparentemente potrebbe sembrare che questo sia il reportage di una crisi, e lo è! Ma appunto la crisi è potente perché una crisi è sempre più di se stessa perché riapre i fattori in gioco.
A pagina 81, lei, professor Roy, dice, come nota Bill Readings, che gli studi culturali non sono la causa, ma la conseguenza della crisi della cultura. Così come il matrimonio omosessuale non è la causa, ma la conseguenza della crisi del modello familiare. Quindi bisogna capire come stanno veramente le cose.
Ma allora potremmo chiederci quale sia il vero motivo della crisi della cultura se è vero che questa crisi è la conseguenza di un fenomeno che, forse, ci sfugge. Cioè è facile dire «crisi», ma non è facile capire in cosa consiste veramente.
Come dico sempre ai miei studenti, nella società contemporanea il vero problema è che non si veda il problema, cioè sfugge il problema, non lo si può descrivere perché ciascuno ha un ampio prontuario di fenomeni che sono andati in crisi, basta aprire i giornali, è evidente.
Ma se ci si chiedesse: a cosa è dovuta questa crisi? Qual è la vera posta in gioco? Non è molto semplice. Potremmo di volta in volta scegliere uno schema di riferimento, ma questo non ci fa fare un passo avanti.
Dico di capire il vero motivo della crisi non semplicemente per farci una teoria su, ma per capire in che modo la crisi ci coinvolge perché se ci fosse una crisi senza che noi ne fossimo interpellati è qualche cosa che lascia il tempo che trova.
Noi rischiamo sempre di vedere molto bene le conseguenze, ma non sempre cogliamo la causa. Ora Olivier Roy ci fa capire molto bene che la deculturazione ha sostituito il pensiero implicito, la simbolizzazione condivisa e l’esperienza con una serie di codici, con una estrema codificazione il cui principio è una «normatività capillare».
Di tutto bisogna dare le norme per stare in una comfort zone, in una safe zone in cui non si sbaglia. Bisogna mettere le mani avanti. Ciò vuol dire che è venuta meno la possibilità di cogliere e di percepire il problema dell’umano, cioè il problema che è l’umano.
Questo sembrerebbe qualche cosa di scontato, ma è la cosa meno scontata e, non a caso, la frase finale di questo testo è: quello che noi viviamo è in effetti una crisi dell’umano.
Dire che tutta la crisi del globish, del gender, della codificazione algoritmica della società sia una crisi dell’umano è una tesi tutt’altro che ingenua e tutt’altro che scontata, ma va assolutamente pensata.
Per me il punto critico è il seguente: la crisi della cultura, cioè l’appiattimento del mondo, ha completamente silenziato la voce dell’umano? Quella voce che si chiama «io» ha ancora una risorsa per farsi sentire? L’«io» stesso è capace ancora di ascoltarla?
Perché l’«io» è disabituato ad ascoltare la sua voce. È la propria voce che è estranea all’«io», quindi non è tanto una rivendicazione antropocentrica o antropologica che l’«io» fa rispetto al mondo, ma innanzitutto un riappropriarsi della propria voce.
Questo secondo me è il punto più aperto di questo libro perché solamente in qualche punto Roy sembra dirlo esplicitamente, ma lo dice implicitamente in ogni pagina. C’è qualcuno che può ascoltarla ancora questa voce dell’io e farsi ascoltare da se stesso?
Qui si gioca totalmente il problema della crisi perché se la crisi ha roso talmente l’«io» allora è già fatto, ma è lecito dubitarne perché per descrivere la crisi come la descrive Olivier Roy ci vuole un «io» in azione, altrimenti questo libro non sarebbe stato neanche scritto.
[O. Roy]
Sono totalmente d’accordo con l’analisi del professor Esposito. Ciò che è in gioco è proprio la questione dell’umano, il posto dell’umano, la posizione dell’umano.
Non credo affatto che l’essere umano sia mutante, che si stia evolvendo e trasformando in un’altra forma di creatura. Il problema è proprio il posto che occupa oggi questa nozione di umano e questo ha due livelli.
Il primo è nel rapporto con l’animalità ed è chiaro che oggi sia o un’estensione dell’animalità verso l’umano o una confusione tra animalità e umano. Per esempio c’è stata l’introduzione del concetto dell’essere che risente, che soffre, quindi, per esempio, i difensori dell’antispecismo sostengono che l’animale ha una personalità giuridica in quanto capace di soffrire.
In tempi recenti si assiste alla fine della separazione tra il genere umano e il genere animale che era il fondamento dell’antropologia. E contemporaneamente si assiste all’evoluzione dell’intelligenza artificiale che occupa sempre più lo spazio che fino ad ora era occupato dal genere umano.
Quindi l’essere umano perde il monopolio di due cose: 1) della ragione che la prende l’intelligenza artificiale 2) del sentimento che lo prende l’animale.
Il secondo livello è che cosa ci si aspetta dall’essere umano. Ci si aspetta che si esibisca, vale a dire che dica tutto di sé in maniera esplicita e pubblica ed è questo che è nuovo.
Ci sono due pratiche che stranamente sono in crisi da una ventina d’anni: la confessione cattolica e la cura analitica. Vale a dire che nell’uno e nell’altro caso l’uomo l’individuo tenta di spiegare se stesso, ma ci sono due limiti: 1) nella confessione il segreto della confessione 2) Nella cura analitica la protezione della privacy.
Ci sono altri due punti in comune nella confessione e nella psicanalisi, cioè si sa che l’esplicito non è mai totale, non è mai al 100%, c’è sempre qualcosa che resiste. Nel caso della confessione è il peccato, nel caso della cura analitica è l’inconscio.
Oggi assistiamo a un attacco rispetto a queste due cose, quindi c’è la richiesta della soppressione del segreto della confessione e la negazione della psicanalisi in quanto pratica medico-scientifica.
Sono due offensive non coordinate, non c’è un complotto contro la confessione e la psicoanalisi. Quello che è nuovo è l’esigenza di una esplicitazione totale. La cosa interessante è che gli individui accettano tutto ciò, lo richiedono, lo vogliono, chiedono di potersi spiegare, per esempio su Facebook, di confessarsi, di esternare le proprie emozioni. Richiedono un riconoscimento del loro modo di presentare loro stessi.
Quello che oggi è in causa non è il segreto, ma l’ineffabile che secondo me è proprio al cuore della nozione di umanità.
[C. Esposito]
Io credo che il primo contributo è quello di rendersi conto, cioè di esserci veramente nei confronti di quello a cui la situazione in cui noi viviamo ci sfida. Normalmente, rispetto ad un’analisi come quella che stiamo facendo della nostra situazione, l’unica possibilità di fuoriuscita è quella di riaffermare qualcosa che ci sembra che sia compromessa. Oppure di accelerare il processo perché finalmente si arriverà alla nuda verità dei fenomeni.
Riaffermare quello che si è perso, per esempio, è riaffermare la centralità dell’umano come qualche cosa che è già stabilito una volta per tutte. È già una struttura a priori. Noi lo sappiamo già e lamentiamo la sua perdita. Bisogna cioè ritornare all’umano come un valore assoluto, per difenderlo dall’erosione della crisi contemporanea.
Bisogna rimettere l’umano nella sua natura. Quella che si è persa è la natura, appunto, assediata dall’animalità. Eppure tutti quanti noi sappiamo che c’è dell’animalità in noi. Quindi il problema non è tanto ribadire la differenza dell’umano rispetto all’animale, ma di capire cosa vuol dire per noi umani essere degli animali. In che modo noi viviamo l’animalità? Perché è lì che si gioca tutto.
Che cosa la nostra stessa istintività ci porta a desiderare? Ci basta la soddisfazione dell’istintività?
C’è un famoso teorico della coscienza riduzionista, forse il principe dei riduzionisti, americano, che ha scritto un libro, Sweet dreams, cioè “sogni d’oro”, dicendo che in fondo la coscienza è un’illusione. È una dolcissima illusione senza la quale, ahimè, ancora non siamo abituati a vivere, ma arriverà (ci siamo quasi, ma avrei dei dubbi) il momento in cui noi capiremo che è soltanto una certa organizzazione culturale dei nostri processi biochimici neurali.
Dopo che lui scrive questo libro dice: comunque questo non vuol dire assolutamente negare tutta la capacità di affettività, tant’è vero che io ho bisogno di accarezzare il mio gatto, la sera, di fargli fare le fusa per gustare anche la dolcezza della vita, ma è una tecnica illusoria perché si brucia tutto quanto nel feeling.
Allora per vivere, in ogni caso, abbiamo bisogno di qualche cosa che sia più dell’istinto, ma quando andiamo a spiegare chi siamo non possiamo che ridurci a quella animalità che ci assedia sempre di più. Il problema è proprio questa discrepanza.
La via maestra per risolvere la crisi è capire che cosa ci chiede. Io non so se la nostra generazione risolverà questa crisi o se imploderà il mondo. Non lo so. So soltanto quello che mi chiede e ci chiede in questo momento e cioè di non tralasciare la nostra esperienza.
Piuttosto che rivendicare la primazia, la centralità, l’irriducibilità dottrinale dell’umano rispetto all’animale, cerchiamo di capire che cosa accade nella nostra esperienza che anche è sempre esperienza animale.
Noi possiamo fare esperienza di trascendenza perché siamo animali. È grazie alla nostra animalità che noi possiamo capire che non siamo toujours animalità, che trascendiamo l’animalità, ma bisogna passarci. Capiamo di che razza di materia è fatta la nostra spiritualità perché abbiamo un corpo. È soltanto perché viviamo il nostro corpo che possiamo intuire che cosa sia essere degli enti spirituali.
Allora non si tratta di ridefinire a priori la natura dell’uomo, ma di farci attenti dei fattori dell’esperienza a volte proprio partendo da quelli che ci sembrano le riduzioni dell’esperienza stessa.
Questo secondo me non mette dei limiti alla comprensione dell’umano, per cui mi piace dire che se l’umano è il problema che va in crisi esplicitamente e in una maniera nuova come nel libro di Olivier Roy ci è dato di capire, dall’altra parte è anche vero che l’umano è il nome di una crisi.
Ditemi se c’è stata un’epoca in cui l’umano non è stato una crisi. L’essere umano è proprio questo. È un essere che mette in questione il mondo perché cercare il senso del mondo nell’istinto che sembrerebbe più bruciato, più autoreferenziale, di un rapporto sessuale, per esempio, che lì dentro emerga come un fiore di tenerezza perché uno possa dire alla persona con cui sta: «ma chi sei tu?», «com’è che ti ho incontrato?».
Questo emerge dall’interno dell’istinto, non è un altro mondo. Questo è il momento di crisi perché mette in crisi l’azione-reazione, mette in crisi il puro meccanicismo del rapporto.
Quindi da sempre l’essere umano è il nome di una crisi e questo cosa vuol dire? Non che saremo sempre in una situazione di crisi insuperabile, ma che dobbiamo come renderci conto che non ci è risparmiato questo lavoro di riappropriazione di noi stessi che si può fare solo e sempre attraverso una crisi.
Probabilmente gli aspetti della crisi del nostro tempo sono aspetti che ci possono non piacere, che ci possono essere particolarmente ostici, però mi viene da dire che questo è il nostro tempo e non sto dicendo che va bene così, no! Ma non sto neanche dicendo che, siccome va male così, bisogna ritirarsi dal proprio tempo o fare una fuga in avanti. Bisogna starci.
Allora io non saprei dire – magari questo lo chiederò al professor Roy – come se ne esce, però io credo che questa non sia la domanda più interessante. È urgente, è chiaro, però la vera domanda è che cosa ci chiede, perché solamente se io capisco che cosa mi chiede posso capire e ipotizzare come se ne esce, che è il problema dell’educazione.
Con i nostri studenti, con i nostri figli, qual è l’ideale dell’educazione? Non dare delle vie di uscita, ma fargli capire qual è il problema, fargli capire qual è la crisi, perché ciascuno possa uscirne, ma come se ne esce?
O esplicitando, ma non se ne esce esplicitando perché noi ci portiamo dentro quell’implicito che è oggettivo, non possiamo tirarci fuori. Oppure capendo qual è il problema, qual è il punto.
Mai come in questo momento – con buona pace di Max Weber – il metodo dell’analisi è così vicino al metodo della testimonianza e uso questo termine in senso molto laico, cioè di attestare uno sguardo.
La mia analisi sulla situazione di crisi è convincente se comunica uno sguardo che aiuti a capire in che cosa io sono coinvolto, perché ci sono tantissimi libri di analisi in cui, però, non si capisce il problema. Sì, ci si informa.
Secondo me il libro di cui stiamo parlando stasera è un libro che ci aiuta a capire il problema per poterne uscire, ma che non pone innanzitutto la questione: «allora, che fare?»
Il libro sul nichilismo che ho scritto è in preparazione per l’edizione americana. Gli americani han detto: il libro va benissimo, però bisognerebbe scrivere una conclusione in cui si dica «allora, che fare?». È la normatività, il codice, l’esplicitazione.
Io ci ho pensato un po’, volendo – diciamo – far breccia sul pubblico americano. Ho pensato di poter elaborare una via d’uscita, ma non funzionava e con sincerità ho potuto solamente dire a loro, ma a me stesso innanzitutto, che la prima via di uscita, la prima risposta è capire veramente la domanda che siamo noi.
È la domanda che questa situazione, così omologata, ci chiede. Cioè se nell’appiattimento c’è qualche cosa che resiste, se ci sono dei punti di resistenza, se c’è come un bandolo della matassa. Ecco, questo è il punto.
È come se la nostra situazione fosse arruffata e anche tanti libri, tante analisi contribuiscono ad arruffarla, cioè a complicarla mentre il problema non è di semplificarla in maniera semplicistica, ma di trovare il bandolo per poter con pazienza riguadagnare il filo.
È questo il punto, ma questo bandolo è qualche cosa di cui noi facciamo esperienza perciò la competenza è dell’analista, ma ogni grande analista – e mi permetto di dire senza piaggeria che Olivier è un grande analista – è colui che ci aiuta a trovare la competenza personale, a trovare ciascuno quel bandolo per cui si possa decifrare l’enigma del tempo.
[Marco Bardazzi]
Credo che sia molto interessante chiedere una sua indicazione di metodo, non tanto il come se ne esce, ma qual è il metodo con cui starei di fronte a questa realtà. E se non banalizzo troppo, vorrei chiedere un metodo anche per stare di fronte a quegli strumenti digitali che lei indica come parte del problema.
Mette le faccine degli emoticon sulla copertina del libro spiegando che non si può più dare niente per implicito, ma l’esplicito deve essere: «guarda che sto per fare una battuta, ti metto la faccina, attenzione, sto per dire una battuta» perché non si può più dare niente per scontato.
Qual è il metodo per vivere in maniera più umana anche questo mondo tecnologico che lei descrive come parte rilevante del problema?
[O. Roy]
Il problema con la cultura internet, che è oggi la cultura dominante, è che si incontrano soltanto persone che ci assomigliano, persone che, come noi, si definiscono attraverso determinati tratti che possono essere razziali, sessuali, gusti, ma tratti espliciti che si condividono con queste altre persone.
Oggi la parola dominante è la parola “identità”. Tutti ne parlano. Ovviamente la parola esisteva anche prima, è da vent’anni che la si usa in questo modo, prima pur esistendo la si usava in maniera diversa, e tutti tentano di definire la propria identità.
Si cercano persone con le quali condividiamo questa stessa identità, da qui anche l’uso degli emoji o di altre cose, ma questo spiega anche gli “speed date”, cioè degli incontri che durano tre, sette minuti che ti permetterebbero di trovare una persona con la quale ti intenderai alla perfezione.
Si cerca quindi il simile, si assomiglia al simile, si finisce in subculture internet all’interno delle quali ci si scambia le stesse idee e la conseguenza logica è che chi ti assomiglia odia gli altri, quindi ci si trova in una struttura binaria dove c’è chi ti assomiglia e tutti gli altri.
Invece nella vita vera, nel lavoro, nelle relazioni di vicinato, in famiglia, si è portati a incontrare delle persone che non ci assomigliano con le quali ci sono delle incomprensioni, dei conflitti, dei silenzi.
Io sono convinto che la chiave stia proprio in questo, cioè ritrovare il legame sociale, ritrovare le persone al di fuori di questa bolla internet. Tutte le tendenze invece oggi premono per restare all’interno di questa bolla, soprattutto nel lavoro.
Ciò che mi rende pessimista è proprio questo, cioè che si sta andando verso una accentuazione del virtuale. L’unico modo per andare contro a questa tendenza è la volontarietà, cioè il desiderio, la volontà di uscire da questa bolla e ricostituire il legame sociale.